Gli italiani litigano per le ricette tradizionali, come facevano i greci per Omero: ci si immola per la paternità di tortellini e parmigiane. La cucina italiana esiste, ed è identità pura.
di Teresa Borriello
Si narra di un’antica usanza secondo la quale ben sette “pòlis” dell’Asia Minore rivendicavano l’onore di essere la città natale di Omero. La contesa fu così aspra che ispirò un celebre distico latino: “Smyrna, Rhodos, Colophon, Salamis, Chios, Argos, Athenae — / Orbis de patria certat, Homere, tua” (Smirne, Rodi, Colofone, Salamina, Chio, Argo, Atene — il mondo intero si contende, o Omero, la tua patria).
In Italia, siamo più prosaici, anziché rivendicare la natalità di un grande poeta nazionale, ci battiamo per la paternità di una ricetta. L’intensità del nostro amore verso il cibo è pari alla devozione per un culto religioso. Bruciamo di un’intensa passione dinanzi alla nostra tradizione imbastita in un piatto.
Non ci limitiamo a identificarci con delle specialità culinarie entro il confine della nostra città o entro il perimetro della nostra regione. Scendiamo nei dettagli, distinguiamo ciò che si prepara nei singoli quartieri e nelle case stesse. Disprezziamo con forza le variazioni contenute in altre ricette. A Napoli, patria di fini distinguo culinari, si discute con accanimento se sia superiore il ragù della Sanità rispetto a quello del Vomero. Ogni famiglia, ogni nonna, ogni cuoco, custodisce un incomunicabile segreto – che si tramanda come nella migliore delle tradizioni orali, solo a pochi sodali di generazione in generazione.
L’idea che una ricetta subisca delle variazioni, anche impercettibili, viene percepita come un affronto, una profanazione. Questo sacrilegio offende la storia di un popolo, e di una comunità. Una ricetta rappresenta l’identità di una popolazione e l’idea che un’altra città o comunità possa rivendicare la paternità di quel piatto è vissuta come un attentato gravissimo, che può scalfire l’identità della gente.
Ancora oggi si battaglia per stabilire se la ricetta della carbonara prevede all’uso della pancetta o del guanciale o se nella amatriciana ci va la cipolla. Ci si scaglia contro chi usa la panna per la cacio e pepe o l’ananas sulla pizza. Si attacca energicamente chiunque metta in discussione la provenienza della cotoletta milanese.
I nostri piatti sono mitici, al pari dei versi di Omero, perché costituiscono le fondamenta della nostra identità. I greci avevano i versi di omero; noi abbiamo la parmigiana di melanzane.
Tortellini, Ragù, Fettuccine Alfredo, Parmigiana, Tiramisù, Cassata, Panettone: scopriamo sette ricette originali la cui paternità è contesa tra varie città o protagonisti.
Per i tortellini, una guerra senza fine: sono bolognesi o modenesi?
Il tortellino, la cui forma pare essere ispirata all’ombelico di Venere – secondo un’antica leggenda -, è il protagonista della disputa tra Bologna e Modena. L’epica battaglia sulla paternità dei celeberrimi tortellini si combatte tra le due città da tempo immemorabile. I bolognesi sostengono fermamente che la ricetta sia nata nelle loro taverne, nel Medioevo. I modenesi, invece, ne rivendicano la paternità sostenendo che il primo tortellino della storia fu realizzato proprio presso la locanda della Corona di Castelfranco Emilia.
Bolognesi e modenesi non sono d’accordo neppure sulla gloriosa storia dell’origine del tortellino. Per i bolognesi un oste sbirciò la dea Venere dal buco della serratura, e a quell’immagine si ispirò per la forma dei propri tortellini; secondo i modenesi fu un oste di Castelfranco Emilia a scrutare l’ombelico della dea.
Tuttavia, la Camera di Commercio di Bologna depositò ufficialmente la ricetta presso l’Accademia Italiana della Cucina, nel 1974. Nonostante ciò, i modenesi continuano a reclamare l’appartenenza dell’autentica ricetta del tortellino.
Ancora oggi, variazioni apportate alla ricetta creano dispute e dibattiti immensi.
Il ragù alla bolognese è veramente bolognese?
Quante domande affollano la guerra per la paternità del vero ragù alla bolognese: deve esserci il latte o no? Quanto pomodoro prevede la ricetta? E la carne? Che tipo di carne prevede la ricetta?
La ricetta principale del ragù alla bolognese è stata depositata alla Camera di Commercio di Bologna nel 1982. In molti, però, osteggiano la ricetta presentata. Gli imolesi sostengono di essere detentori della ricetta tradizionale; altri abitanti di altre zone dell’Emilia-Romagna rivendicano di essere in possesso di varianti locali che precederebbero la ricetta bolognese ufficiale.
Tuttavia, la verità è che ogni famiglia emiliana ha la sua variante che risiede nell’uso o nel dosaggio di un ingrediente specifico. Ognuno conserva la propria tradizione e la propria autenticità. La ricetta del ragù di famiglia è tramandata, ed è preziosa. Per questo, modificare la ricetta è un abominio.
Le Fettuccine Alfredo conquistano l’America, noi li disconosciamo e gli americani se ne appropriano
Le Fettuccine Alfredo sono nate a Roma nel ristorante di Alfredo di Lelio. La storia narra che Alfredo inventò questa ricetta per sua moglie, che all’epoca era incinta.
Due ristoranti romani ne rivendicano la paternità. La contesa tra “Alfredo” in Via della Scrofa, ora gestito dalla famiglia Mozzetti e Il “Vero Alfredo” all’Augusteo è sempre aperta.
Questo delizioso piatto, tuttavia, ha conquistato gli Stati Uniti, dove sono diventate più celebri di quanto lo siano in Italia. E sono anche un sugo pronto che si vende in barattoli in tutti i supermercati. Per questo, la disputa per la paternità delle fettuccine Alfredo si è pure inasprita divenendo una contesa internazionale.
Alcuni chef americani sostengono di aver reso la ricetta perfetta, così si è scatenata l’ira dei romani legati alla propria ricetta tradizionale.
Questo piatto, divenuto più americano che italiano, rappresenta un vero e proprio paradosso per l’identità culinaria italiana. Ancora oggi, i ristoratori romani vivono questa crisi identitaria; questi dicono di sentirsi derubati della propria identità.
La Parmigiana è campana, calabrese o siciliana?
La parmigiana di melanzane è un piatto gustoso e amatissimo, in tutto il mondo. A Napoli è tra i piatti più celebri. Per la parmigiana di melanzane sono tre le regioni a scontrarsi per aggiudicarsi il titolo di madre della ricetta. La contesa è così potente che vi sono sagre tematiche dedicate proprio alla faida tra le regioni – Campania, Calabria e Sicilia.
Per i siciliani la parmigiana è nata in Sicilia. Secondo loro, il nome di questa pietanza, addirittura, deriva dal siciliano “parmiciana”, ovvero persiana: questa dicitura si riferirebbe alla disposizione degli strati delle melanzane.
La Calabria asserisce che la ricetta originale della parmigiana sia nata proprio in Calabria, invece.
La Campania, la cui parmigiana è tra le più opulente e conosciute, afferma che la sua ricetta antichissima è nata nei conventi napoletani del XVIII secolo.
Ogni regione ha le proprie varianti intoccabili. I siciliani aggiungono alla ricetta uova sode e piselli. I calabresi usano unicamente la melanzana rossa di Rotonda. I campani insaporiscono la ricetta con basilico fresco.
Il Iiramisù: il dolce italiano più famoso al mondo è veneto o friuliano?
Una storia narra che il tiramisù fosse il dolce afrodisiaco per eccellenza. Il “Sbatudin”, il dessert a cui si è originariamente ispirato il tiramisù, nacque nelle case chiuse del Friuli-Venezia Giulia.
Un’altra storia, invece, – meno colorita -, racconta che un dolce simile fosse servito in alcune osterie venete già nell’Ottocento. Divide, per l’appunto, l’intero Nordest dell’Italia. I veneti sostengono che la ricetta originale del tiramisù è nata nel 1969 al ristorante “Le Beccherie” di Treviso, inventato dalla pasticcera Alba Campeol. I friulani riportano che questo dessert fosse già molto in voga nelle case friulane già dagli anni ’50.
Nel 2017 Treviso ha chiesto il riconoscimento UNESCO per il tiramisù e il Ministero delle Politiche Agricole ha riconosciuto ufficialmente il tiramisù come dolce friulano, una decisione contestata da alcuni, tra cui il governatore del Veneto Luca Zaia.
Sfumature di Cassata, sfumature di Sicilia
Pure nelle pasticcerie siciliane, la cassata siciliana genera contese e dispute pungentissime. I palermitani rivendicano la paternità della cassata siciliana. Questi affermano, senza alcun dubbio, che sia nata nei conventi arabi della città durante la dominazione islamica.
Messina, Catania e altre città siciliane hanno le loro ricette originali – per la cassata.
Ogni dettaglio della ricetta è protagonista di questa immensa battaglia: il tipo di ricotta, il pan di Spagna, la glassa di zucchero, i canditi. Ogni pasticceria siciliana crede di conservare il cimelio più autentico della tradizione; la ricetta della cassata è gelosamente tramandata da generazioni di pasticceri.
Una cosa è certa: la Cassata palermitana e quella catanese sono diverse. Quella palermitana, infatti, avendo come strato superiore la tipica pasta reale, risulta essere molto più dolce rispetto a quella catanese. La Cassata Siciliana catanese, invece, è meno dolce perché al posto della pasta reale si utilizza la glassa di zucchero. Non azzardatevi a chiedere quale sia il vero cannolo.
Panettoni milanesi e veronesi: una diatriba immensa, tra lievitazioni e leggende
Tutti sanno che la ricetta del panettone abbia origini milanesi. La leggenda narra che nacque dalla storia d’amore tra un garzone di forno e la figlia di un pasticciere, nella Milano del XV secolo.
I veronesi, tuttavia, credono fermamente che la ricetta del loro panettone, il “Nadalin”, esistesse ancor prima della storia d’amore tra il garzone e la figlia del pasticciere.
Tuttavia, nella stessa Milano, la leggenda sull’origine subisce variazioni e variazioni. Ogni storica pasticceria milanese custodisce gelosamente la propria ricetta tradizionale.
Oggi, milanesi e veronesi, si scontrano sugli ingredienti utilizzati e sulla qualità stessa degli ingredienti.
Per esempio, i puristi difendono la versione priva di canditi, uvetta o cedro.
Il campanilismo culinario ci dice qualcosa di più: è custode della memoria
La Cucina Italiana esiste – a differenza di quanto afferma qualche professorone pur di creare hype per vendere i suoi libri. Grazie al campanilismo culinario si difende, attraverso il cibo, una memoria fatta di piatti e ricordi. Intorno ai ricettari d’un popolo si sono costruite vicende che riescono ad essere sugellate proprio in quegli irripetibili sapori e odori che si sollevano dai piatti, che sembrano essere irreplicabili ad di fuori dei propri territori di provenienza.
Ogni disputa sulla paternità di una ricetta tradizionale cela un messaggio più sottile e profondo: è l’orgoglio di identificarsi, di appartenere a una comunità grazie alla stessa storia e alle medesime tradizioni.
Il cibo raccoglie e sugella la volontà di preservare un patrimonio culturale immane, che si tramanda proprio grazie alla stessa passione che si manifesta al momento della difesa di questa o di quella ricetta tipica. La prima codifica per iscritto della Cucina Italiana è avvenuta nel 1891 con la pubblicazione de La Scienza in cucina e l’arte di mangiar bene di Pellegrino Artusi, che ha raccolto ricette regionali creando un linguaggio culinario comune e dando voce a un’identità nazionale attraverso il cibo.
Come direbbe qualsiasi italiano, “Non è solo cibo. È la mia storia.” E in questa storia, fatta di nonne che tramandano segreti culinari, di ricette che si evolvono mantenendo la loro anima, di territori che si riconoscono nei loro sapori, la Cucina Italiana non solo esiste, ma vive e respira in ogni disputa, in ogni difesa appassionata, in ogni variante gelosamente custodita.
Le sette città che si contendevano Omero sono quasi scomparse nella polvere della storia. Le città italiane che si contendono tortellini, ragù e tiramisù continuano a cucinare, innovare e tramandare. E questa, forse, è la più bella vittoria di tutte.
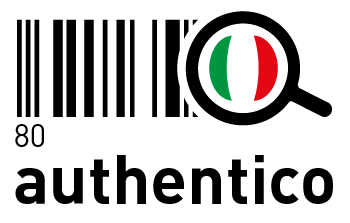


Riduzione dazi USA sulla pasta, la vera opportunità non è il prezzo, ma la prova di autenticità
L’annunciata riduzione dei dazi antidumping americani sulla pasta italiana non è solo una boccata d’ossigeno [...]
Gen
Ecco i 10 trend dell’Agritech & Foodtech per il 2026
L’Osservatorio di Authentico ha incrociato i dati di mercato e le analisi dei principali report [...]
Dic
La sostenibilità alla prova della realtà: tra ambizioni climatiche e limiti operativi
La sostenibilità piace ai consumatori, ma sono in pochi quelli disposti a pagare di più [...]
Nov
E’ possibile un mondo senza mucche?
Cosa accadrebbe se domani sparissero le mucche dalla faccia della Terra? Un’ipotesi che sembra assurda [...]
Set
L’epica gastronomica del Bel Paese: la cucina italiana esiste e siamo pronti a combattere a spada tratta per difenderne la paternità
Gli italiani litigano per le ricette tradizionali, come facevano i greci per Omero: ci si [...]
Set
Perché l’olio evo è l’alimento italiano più contraffatto
L’olio extravergine di oliva (EVO) è uno dei pilastri del Made in Italy alimentare: simbolo [...]
Set